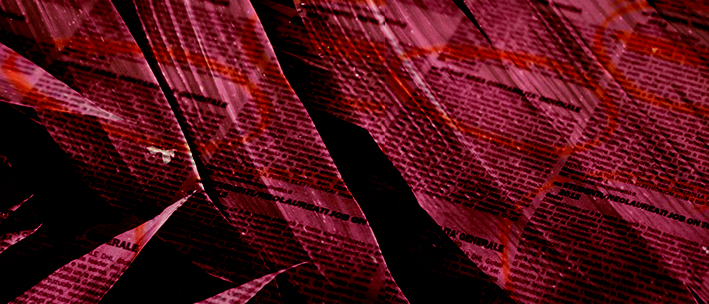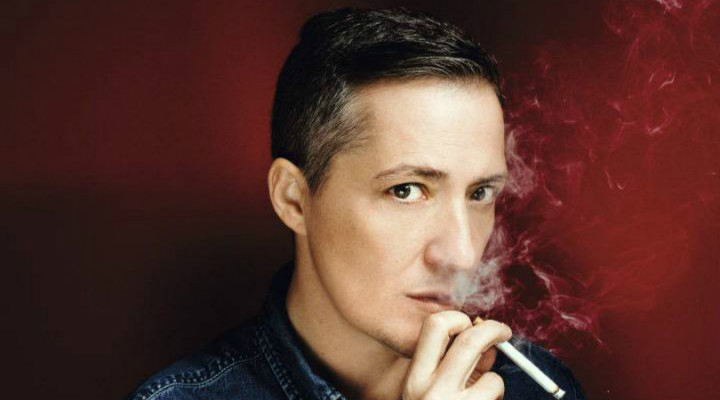Elisa Casseri / 19 luglio 2019
«Parli solo della struttura di questo libro»
«Non è vero»
«E le quattro voci… E i salti temporali… E i rapporti simbiotici…
E il ciclo delle piante… E le stagioni che permutano… E poi le micorrize…»
«Ma perché mi stai sgridando?»
«Perché fai sembrare il tuo romanzo un libro complesso. Vuoi che sembri un libro complesso?»
«No, che non voglio. Anche perché non è un libro complesso»
«Invece È un libro complesso, ma non lo deve sembrare»
«Non ho capito»
«La complessità è una cosa bella solo se non la dici. Se la dici, se cerchi di spiegarla, disorienti»
«Quindi per non disorientare devo mentire?»
«No, non devi mentire. La devi smettere di parlare SOLO della struttura di questo libro»
«Vabbè, a me sembra che mi stai chiedendo di mentire. E poi guarda che le micorrize…»
«Dio ce ne scampi e liberi da queste dannate micorrize…»
[Conversazioni su La botanica delle bugie, 2019]
C’è stato un periodo, dopo la laurea, in cui ho risposto a un sacco di annunci di lavoro. Sapevo che non volevo fare niente che c’entrasse con quello che avevo studiato, ma ero in quell’interregno strano (che, devo ammettere, non ho mai veramente abbandonato) in cui, mentre si cerca di capire in che modo gestire filosoficamente la scrittura e la vita, si sa che si deve pure pagare l’affitto e allora tanto vale muoversi.
Ho fatto dei colloqui insensati, durante i quali ho reagito con impeccabile concretezza a domande come «Dove ti vedi tra cinque anni?», non credendo a nemmeno una delle parole che pronunciavo. Mi ricordo che, una volta, dopo aver risposto a un annuncio molto vago, mi sono ritrovata a fingere una sapienza econometrica di fronte alla donna che mi doveva valutare e che, appena mi sono seduta, mi ha detto che mi sarei dovuta occupare della cessione del quinto.
«Sa cos’è la cessione del quinto?».
«Certo che lo so», ho risposto io – che non lo so nemmeno adesso cosa sia la cessione del quinto.
È stato il periodo in cui ho domandato tantissime volte a me stessa quello con cui, per tutto il resto della vita, ho ossessionato ogni persona con cui ho avuto a che fare.
Dopo ogni giornata passata a rispondere agli annunci, dopo ogni telefonata in cui cercavo di convincere qualcuno della sensatezza di quello che stavo facendo, dopo ogni terribile colloquio in cui portavo il mio curriculum in formato europeo e raccontavo la mia tesi e le mie skills, mi guardavo in uno specchio e me lo chiedevo.
Pure oggi, a cosa è servito mentire?
Ovviamente non sono riuscita mai a darmi una risposta soddisfacente, così come non ci sono mai riusciti, per tutto il resto della vita, mia madre, mio padre, il mio migliore amico, il prete, il professore di Meccanica dei solidi, l’allenatore di salto in alto, mia nonna, il dirimpettaio, il cane di quartiere. Non c’è riuscito nemmeno un mio fidanzato musicista che, all’inizio, sembrava essere un estimatore della verità – mi diceva di saper riconoscere i miei «Sì» veri da quelli finti perché questi ultimi suonavano in bemolle – e poi quando decise di lasciarmi mi disse che lo faceva perché non sorridevo abbastanza.
«In che senso non sorrido abbastanza?», gli chiesi io, senza sorridere.
«Nel senso che non sorridi abbastanza».
Dopo qualche mese in cui ci eravamo lasciati e ripresi, scoprii che si stava sentendo con un’altra ragazza, allora lo guardai intensamente e glielo chiesi.
«Ma non potevi dirmi la verità? A cosa è servito mentire?».
«Non lo so», mi rispose.
Tolta mia sorella, che si è sempre spesa in risposte articolate e di concetto alla domanda «A cosa serve mentire?» (non ultima, ieri pomeriggio, quando mi ha detto: «Mentire è un atto di civiltà»), «Non lo so» è sempre stata una delle risposte più gettonate. In qualsiasi tempo verbale, tono vocale o clima emotivo io abbia declinato quella domanda, «Non lo so» è stata una reazione sempre molto usata. Forse perché è vera?
Non lo so.
So che si mente per ottenere un lavoro o per poterlo lasciare. So che si mente per riuscire ad amare o per lasciarsi odiare. So che si mente per gioco o per fatica. So che si mente perché non si sa distinguere una chitarra da un basso o perché si capisce troppo bene la musica. So che si mente per circostanza o per scelta. Insomma, so, come lo sanno tutti, che si mente per tutto e il contrario di tutto. E so (perché ci ho provato) che non è possibile trovare una funzione matematica che definisca il rapporto tra quello che è vero e quello che non lo è.
Per questo, a un certo punto, ho cercato di smettere di indagare, di non accanirmi nello scorticare tutti con le mie domande disorientanti, con i miei tentativi di soluzione, con le strutture nelle quali cercavo di incasellare i processi mentali che mi avevano, li avevano, ci avevano portati a fare, non fare, mentire, non mentire, capire, non capire.
L’ho detto, l’ho giurato: «La smetto». Però poi non l’ho fatto.
In pratica, ho mentito.
E a cosa è servito mentire? Beh, per una volta, mi sono saputa rispondere: mentire, per me, è servito a scrivere La botanica delle bugie, un libro che non parla mai, nemmeno per una volta di micorrize. Lo so che io non faccio che parlarne, ma nel libro non c’è nemmeno un’occorrenza di questa parola. Davvero.
E allora, lo giuro: la smetto.
Da oggi parlerò solo di cessione del quinto.