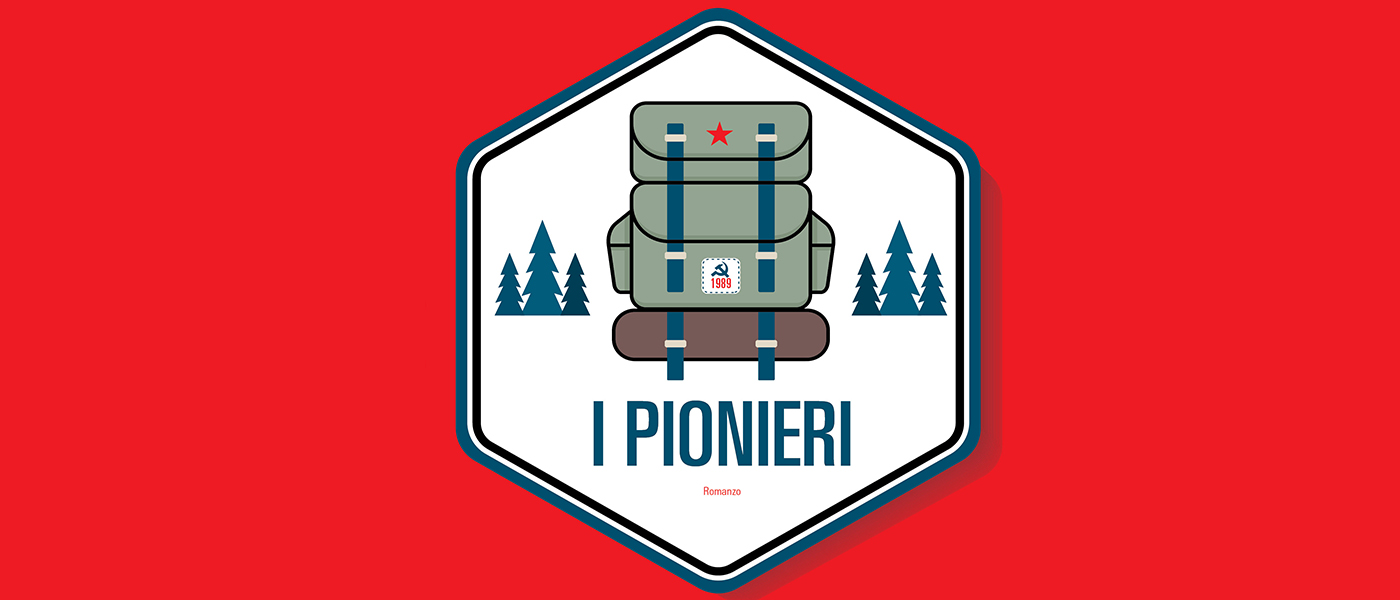Luca Scivoletto / 19-11-2019
L’idea è nata da una visione di scarpe parlanti, le stesse che ho descritto nelle prime pagine del libro. Confesso che quelle attese estenuanti, in sezione, ad aspettare che mio padre finisse di parlare con i compagni del partito, le ho vissute sul serio. E che veramente osservavo quelle scarpe, me ne rappresentavo la voce, il tono. Parlavano di politica, parlavano in dialetto, erano le scarpe di chi aveva voglia di contare, di partecipare. Erano caratteri, atteggiamenti, prese di posizione, critiche, puntualizzazioni. Era la politica vera, in provincia, nel Sud, in Sicilia, la politica dei comunisti, dei rompicoglioni, dei litigiosi, dei verbosi, di quelli che contestavano ogni cosa. Era dissipazione di tempo e di energie, coronarie che si gonfiavano, voci che si rompevano, sigari, sigarette, riunioni, bandiere, manifesti, e scarpe rotte. I comunisti: puri e superiori. Lo erano sul serio? Si è scritto e detto tanto intorno a questa gloriosa «superiorità morale». Oggi mi interessa poco sapere se fosse vera o presunta. Il punto è che, a forza di provarci, qualcuno c’è quasi riuscito, a essere puro. A suo danno, s’intende. Perché qualcuno ci ha anche lasciato la pelle, molti la salute, altri ancora un rapporto normale coi figli, la famiglia, la realtà.
È un mondo sommerso e dimenticato, quello da cui sono partito per raccontare questa storia. Il mondo di chi si è sforzato di essere puro stando ai margini, lontano tanto dalla lotta armata quanto dai salotti dell’intellighenzia, dalla Russia ma spesso anche da Botteghe Oscure; facendola, la lotta, nei consigli comunali, nelle sezioni, nei quartieri. Era un’altra politica quella di cui sono stato testimone, che creava dipendenza, come una droga; e poteva totalizzare la vita, condizionare ogni altra scelta. Questo è avvenuto nella mia famiglia. Anche se voglio rassicurarvi: ne sono uscito vivo. Tant’è che, invece di farvi sorbire un diario dei miei traumi infantili, ho deciso di prendere per il culo me stesso, i miei, la mia infanzia, la mia città, il Pci, e raccontarvi la politica a mio modo, forse con la speranza di “redimerla”, darle un senso che la disincagliasse dalle letture consuete.
Sì, la politica è stato il mestiere di mio padre, la ragione di vita dei miei genitori, e sebbene abbia deciso di occuparmi di altro nella vita, so che con la politica dovrò fare sempre i conti. L’aspetto autobiografico della vicenda,tuttavia, si esaurisce in queste premesse. Perché, diciamolo, anche ai figli dei criminali, o – che ne so – dei mormoni, può capitare di dover fare i conti con la propria tradizione familiare (d’accordo, a me è andata un po’ meglio). E partendo da questo presupposto, il vero sforzo per me è stato quello di trovare la voce giusta perché la storia di Enrico Belfiore e Renato Magenta somigliasse a quella di tanti ragazzini della loro età che, per crescere, devono rompere la bolla di certezze che li ha protetti fin dall’infanzia. La mia bolla si chiamava Pci, ma è quasi un dettaglio secondario.
Quasi. Perché cresceteci voi in mezzo alla «superiorità morale» sul finire degli anni Ottanta, trovatevi voi a essere «figli del Partito» nel momento storico sbagliato, con tutti gli ideali, le fedi e le parole d’ordine assorbite nei primi anni di vita che nel giro di pochi mesi diventano del tutto inservibili. Affrontatela voi, a undici anni, la vostra prima frustrazione identitaria. E il campeggio dei Pionieri? E l’agognata iscrizione alla Fgci a quattordici anni? Ma che Pionieri, che Fgci! Ormai era finito tutto, avevamo scherzato. Restava quindi solo qualche canzoncina e marchi di fabbrica difficili da cancellare. Come, ad esempio, un’opposizione di principio a tutto ciò che fa la maggioranza della gente, a volte senza neanche capirne bene il perché, un senso di opposizione agli «altri» che è rimasto lì, anche dopo che il Muro di Berlino era crollato e il Pci aveva cambiato nome, rendendo quelli come Enrico e Renato dei piccoli disadattati.
Mi ha divertito indagare le reazioni dei miei due protagonisti a un mondo che si trasforma velocemente, senza che loro se accorgano. Enrico e Renato condensano due reazioni opposte rispetto a ciò che hanno ricevuto in eredità e vivono in modo diverso l’obbligo del crescere. Mi è piaciuto anche osservarli da vicino, lungo un anno scolastico, secondo quella dilatazione spaziotemporale che è propria di quella fase tremenda della propria vita che è la preadolescenza. È stato come viaggiare nel tempo. Ha significato ricostruire pensieri, sintonizzarsi con quelle che supponi siano state le loro sensazioni di dodicenni, rimettersi in ascolto di parole, insulti, complimenti, umiliazioni ed esaltazioni ricevute dagli altri. Ma scrivere questa storia ha significato anche abbandonarsi a una divertente indistinzione tra episodi veri e altri mai esistiti, al mescolarsi di ricordi e distopie personali, di realtà e desideri irrealizzati. In fondo, nel raccontare Enrico e Renato, credo di essermi anch’io adattato alla capacità di deformare il mondo, tipica di quella loro bastarda età, facendomi narratore esterno, accettando allo stesso tempo il loro gioco, copiandolo talvolta. Così, pur partendo dalle scarpe, dalla politica, dalla mia famiglia, alla fine sono contento di aver traghettato questa storia oltre l’autobiografia, permettendo ai miei due protagonisti di realizzare le loro fantasie a metà tra il gioco e l’avventura, e in questo modo metterli nelle condizioni di trovare faticosamente un loro linguaggio, cioè crescere.
I Pionieri, quindi, non è un’indagine sociologica sulle famiglie comuniste italiane negli anni ’80. È un libro pensato per tutti, in particolare per chi abbia voglia di riflettere in modo ironico sul peso ingombrante delle eredità familiari, sul chiaroscuro in cui si consuma il passaggio dall’infanzia all’adolescenza; sulla lotta fra ribellione e conformismo che inizia a manifestarsi in quegli anni; sul potere salvifico dell’avventura (nella natura, nell’ignoto, in se stessi, è uguale), quando ci si sente appesantiti da tutte le cose che ci hanno fatto crescere, ma che, almeno in parte, dobbiamo buttare giù dalla mongolfiera per continuare a stare in volo.